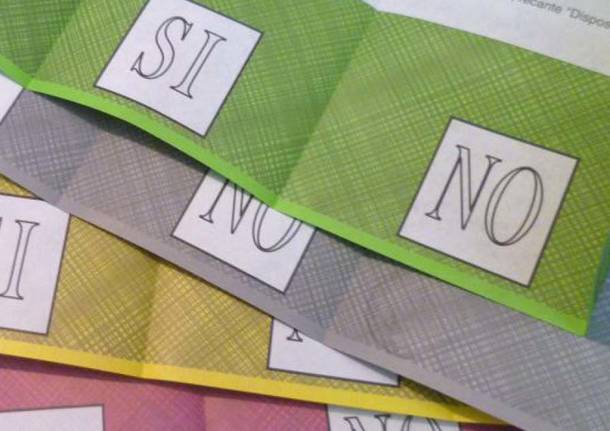Il responso combinato di consultazione referendaria e amministrative ci consegna una situazione “stagnante”: tra i partiti maggiori non uno ha vinto sul serio, nessuno ha davvero perso.
Il trionfo dei sì al referendum (70-30) è però un dato significativo e dallo scrivente inatteso, almeno nelle proporzioni registrate: negli ultimi mesi sul carro del no erano saltati (quasi tutti i) quotidiani a larga diffusione, forze politiche eterogenee e figure pubbliche di spicco, sovrastando con le loro voci stentoree quelle rispettabilissime dei contestatori della prima ora. Con l’eccezione del M5stelle il c.d. taglio lineare era stato rinnegato da pressoché tutti i “padri putativi”: al tiepido e svogliato sostegno di Zingaretti e Salvini avevano fatto da contraltare l’opposizione espressa da molti maggiorenti piddini e la “libera uscita” – evidentemente autorizzata – di autorevoli esponenti della Lega.
Tanto rumore per nulla, verrebbe da chiosare: rispetto all’ambiziosa (e per me scellerata) riforma proposta da Renzi nel 2016 questa leggina costituzionale di quattro articoli in croce era ben misera cosa, limitandosi ad abbassare il numero dei parlamentari da 945 a 600 e a fissare nel massimo di cinque quello dei senatori a vita. Tutto qua: altro che “riforma epocale” (per Di Maio, che s’è comprensibilmente intestato il successo) e “attacco alla democrazia”, che ammesso e non concesso esista ancora sopravvivrà.
Nel merito le ragioni del “no” si facevano preferire a quelle del “sì”, anche se di misura. I sedicenti riformatori vantavano, quali effetti positivi, la riduzione dei costi della politica e un aumento dell’efficienza di Camere snellite di un terzo. Tralasciando il fatto che il risparmio equivale ad una goccia nel mare della spesa pubblica, si tratta di argomenti – o piuttosto di mantra – di schietta ispirazione neoliberista, traducibili nell’endiadi contenimento delle spese e incremento della produttività. Portarli alle estreme conseguenze comporterebbe – coerentemente con le idee che circolano nei piani alti – la soppressione di ogni parvenza di democrazia, visto che i metodi dittatoriali (e le procedure dell’impresa privata, assunta come modello/idolo) sono più rapidi ed efficaci e che un consilium principis di 5-10 persone costa senz’altro meno di qualsiasi parlamento. Invero l’unica argomentazione minimamente persuasiva a favore del sì era ed è la seguente: il via libera al “ritocchino” forzerà le Camere – quelle attuali – ad adeguare se non altro la legge elettorale. Di Maio – visibilmente sollevato per una vittoria che relega in secondo piano l’ennesima disfatta alle amministrative – ha promesso che altri passi seguiranno al primo. Staremo a vedere: nei manifesti di propaganda pentastellati campeggiava l’immancabile lussuosa poltrona (da tagliare)… non molto incoraggiante, per chi chiede alla politica meno bandierine e un minimo di progettualità.
Il “no” aveva, al contrario, qualche buona freccia al suo arco. Come ha riconosciuto il professor Zagrebelsky, pur fautore del sì, “riducendo i numeri, si alza implicitamente la soglia per accedere al seggio parlamentare. Ciò crea difficoltà per i piccoli partiti e porta con sé un effetto maggioritario”. Per l’illustre giurista “questo è un argomento serio, ma non necessariamente a favore del no”. Chi scrive è di tutt’altro avviso: l’articolo 48, comma 2°, della Costituzione afferma che – oltre ad essere personale, libero e segreto – il voto ha da essere “eguale”, e risulta evidente che l’eguaglianza viene meno nell’istante in cui (in conseguenza di sbarramenti od altre alchimie che portano “con sé un effetto maggioritario”) il voto del cittadino a una certa forza politica de facto si annulla… rectius: viene riassegnato d’imperio ad un partito o a una coalizione che ha ottenuto maggior seguito elettorale. Lo spossessamento sostanziale del voto appartiene alla fisiologia nell’evenienza in cui il singolo abbia premiato una lista senza pretese o presentata “per scommessa”, assurge a serio problema democratico se la formazione appoggiata conquista il 2-3% di preferenze… solo il ricorso a un proporzionale puro o con soglie bassissime può tuttavia scongiurare una simile eventualità, che in un sistema maggioritario diviene regola. La questione principale non è allora la quantità di deputati e senatori, ma piuttosto la legge elettorale – anche se il taglio sottintende l’adesione a una logica maggioritaria. Altre critiche alla riformina si appuntano sulla diminuita rappresentanza dei territori e, in particolare, delle minoranze linguistiche (questione sollevata dagli sloveni della Venezia Giulia): in astratto esse mi appaiono condivisibili e non liquiderei sbrigativamente il tema della rappresentanza dei territori definendola “reminiscenza d’un tempo antico, l’Antico Regime (cit. Zagrebelsky, nell’intervista a Il Fatto quotidiano di domenica 20)”. Comunità non è necessariamente sinonimo di “clientela” (l’equazione è figlia di un atteggiamento qualunquista) e un legame diretto tra eletto ed elettori può essere anzi virtuoso, specie ove riferito a territori marginali e “dimenticati”: l’ampliamento delle circoscrizioni elettorali potrebbe sul serio penalizzare periferie ed etnie minoritarie. In teoria l’argomentazione è dunque forte, nella pratica molto meno: all’epoca il caso di un molisano verace “paracadutato” al Mugello fece scalpore (e suscitò ironie), ma oggidì è prassi comune quella di candidare personaggi che delle popolazioni locali e delle loro esigenze nulla sanno né si premurano di sapere. Eliminare le liste bloccate ovvierebbe al problema? Al netto delle ambizioni personali in parte sì… ma ve li ricordate i mister preferenze, personaggi solitamente di modestissima caratura ma provvisti di inossidabili pacchetti di voti? Anche un altro aspetto va lumeggiato prima di chiudere questa veloce parentesi: per una campagna elettorale degna di questo nome – cioè per farsi conoscere dai potenziali sostenitori – servono parecchi soldi, dunque la competizione è truccata in partenza. La soluzione potrebbe consistere in primarie coinvolgenti gli iscritti a ciascun partito, chiamati a scegliere fra più aspiranti ad ognuno dei quali andrebbe garantito lo stesso spazio: i preferiti dalla base andrebbero poi a comporre le liste elettorali. Mi si ribatterà che l’esperienza (del M5stelle) insegna che non sempre in tal modo si selezionano i migliori… verissimo, il meccanismo va senz’altro perfezionato, ma il rischio che a risultare vincitore sia il Cleone di turno è connaturato alla democrazia, che difatti agli studiosi antichi piaceva assai poco.
Insomma c’erano valide – anche se a mio parere non decisive – ragioni di merito per tracciare una croce sul “no” che sarebbe stato tuttavia gravido di conseguenze. Non sbaglia Di Maio quando sostiene che l’attivismo dimostrato nelle ultime settimane da opinionisti, gruppi di pressione e forze politiche era rivolto non tanto contro la riforma, quanto contro il Movimento e il premier Conte: più di qualcuno vedeva nella bocciatura della proposta referendaria l’occasione per liquidare definitivamente i 5stelle e disarcionare il Presidente del Consiglio. Una vittoria dei “no” in concomitanza con la perdita (fino a ieri tutt’altro che inverosimile) di Puglia e Toscana avrebbe inevitabilmente scatenato reciproche accuse di tradimento e una guerra aperta tra i due partner di governo, ma anche il verificarsi della sola prima condizione avrebbe con tutta probabilità posto fine all’esperienza giallorosa.
Avremmo allora avuto i “fascisti” a Palazzo Chigi? Più presumibilmente ci sarebbe toccato uno stimatissimo tecnico che, sostenuto da uno schieramento bipartisan, avrebbe esordito regalandoci il MES… e avrebbe poi messo mano ai problemi “strutturali” del Paese in un’ottica ovviamente “riformista ed europeista”.
Sbaglierò, ma penso che di fronte a questa (sinistra) prospettiva molti concittadini benché poco convinti della bontà della mini-riforma abbiano votato in realtà per Giuseppe Conte, di gran lunga il politico più popolare, e per tenersi questa maggioranza litigiosa, ma resa digeribile dal fatto che le alternative concrete sono di gran lunga peggiori.