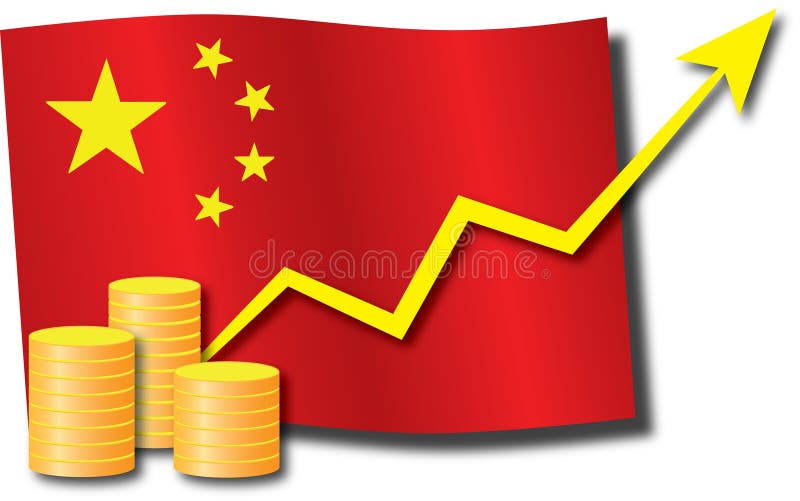Seguo da molto tempo con interesse e stima le riflessioni dell’amico Pierluigi Fagan che a loro volta suscitano in me altrettante riflessioni (sei una risorsa preziosa, caro Pierluigi…).
Ho letto questo tuo post sulla Cina e sul Confucianesimo https://www.facebook.com/pierluigi.fagan/posts/10221645930153137 e, in qualche modo, su questa comparazione che hai proposto tra la storia, la tradizione e la filosofia cinese con quella occidentale.
Intanto sarei un po’ meno severo, tutto sommato, col vecchio Hegel, ormai bistrattato da tutti decisamente “ad cazzum” (a sproposito); non mi riferisco a te, ovviamente, ma ad una pletora di accademici “postmoderni debolisti” oggi non a caso molto di moda. Ma questo è un altro discorso (e il sottoscritto non è un hegeliano, naturalmente, ma proprio per questo, di questi tempi, si sente di assumere la sua difesa d’ufficio, diciamo così…).
Condivido, caro Pierluigi, anche alcuni tuoi commenti in risposta ad altri nei quali, giustamente, ribadisci che non stai qui a fare una sorta di gara a chi ce l’ha più lungo tra la filosofia cinese e quella occidentale (solo degli sciocchi potrebbero pensare questo…).
Venendo a noi, da studioso e lucido osservatore della realtà quale sei, ti chiedi le ragioni del “miracolo” cinese e le individui, appunto, nella storia, nella tradizione e nella millenaria filosofia cinese (confuciana) che oggi, nelle condizioni storiche date, avrebbe permesso il suddetto “miracolo”.
L’analisi che fai è corretta. Tuttavia bisognerebbe chiedersi intanto perché questo “miracolo” – cioè questa incredibile e mai prima avvenuta nella storia, per lo meno in queste dimensioni, accumulazione di capitale in uno spazio e in un tempo così brevi e senza conflitti (ammesso che quest’ultimo aspetto sia un valore, e per noi occidentali e per giunta di formazione marxista non lo è, ovviamente…) – sia avvenuto e stia avvenendo oggi e non prima. Per rispondere a questo quesito sono costretto ad essere banale sia per un deficit personale di conoscenza sia perché su un articolo di poche righe è oggettivamente difficile poter approfondire più di tanto.
Le risposte possono essere due. La prima è che durante il XIX secolo fino alla rivoluzione maoista la Cina era un paese economicamente sottosviluppato, tenuto in condizioni di totale subordinazione e sottoposto ad una dominazione coloniale ferocissima da parte di tutte le potenze occidentali e non solo (penso ovviamente al Giappone) che hanno considerato e trattato per lungo tempo la Cina come una sorta di (neanche tanto) metaforico bugliolo.
La seconda è che dopo la parentesi maoista (comunque fondamentale per liberare il paese dalla dominazione coloniale e gettare le basi, con tutte le contraddizioni del caso, della Cina attuale) c’è stato un matrimonio perfettamente riuscito fra Confucio e Smith (e in fondo anche Keynes e perché no, anche Hobbes e forse in parte anche l’ “Hegel statolatrico”…). Quindi un matrimonio fra la cultura confuciana e parte di quella occidentale (anche se non, ovviamente, con la dialettica e il polemos eracliteo e successivi sviluppi…).
E non c’è dubbio che questo matrimonio, in quel contesto, abbia dato dei risultati straordinari. A patto, però, di contestualizzare e di relativizzare e di ricordare che le loro categorie non sono le nostre. Non c’è dubbio che il “coltivare noi stessi” in Occidente sia stato ridotto, come giustamente dici tu, “a studiare l’inglese e prender la tessera di una palestra” (sono un critico radicale, come sai, della “modernità” o “post modernità” capitalista occidentale…), tuttavia mi sembra di scorgere nelle tue parole un sentimento di “simpatia” per quanto sta avvenendo in Cina (un processo, in parte inedito, di sviluppo capitalistico, con tutte le peculiarità e le specificità del caso) che va oltre la semplice osservazione della realtà che caratterizza lo studioso e il ricercatore. Nulla di male, sia chiaro, è legittimo avere delle “simpatie”. E però su questa strada ti seguo di meno.
Oggi, quel modello (cinese), in quello specifico contesto, è sicuramente vincente. Del resto, quando un paese aumenta il PIL di 123 volte rispetto a 70 anni fa (non so esattamente di quanto dal 1976, anno della fine del maoismo, in poi, ma sicuramente la gran parte, in percentuale, su quei 123 punti) e vede trasformare (in meglio, molto meglio) la vita di centinaia di milioni di persone (e altre centinaia di milioni uscire dalla povertà), pur con tutte le necessarie contraddizioni del caso (aumento vertiginoso e parossistico delle diseguaglianze sociali) sarebbe sciocco limitarsi a demonizzarlo per ragioni ideologiche. Certamente, la qualità della vita di un popolo e di una società non si misura con il PIL, come sosteniamo da sempre noi critici delle società capitaliste-liberiste-industrialiste-sviluppiste-consumiste occidentali e tuttavia in quello specifico contesto (quello cinese) il PIL ha il suo (grande) peso. Così come lo ha avuto da noi in Occidente per lungo tempo, diciamo nella fase un po’ più relativamente “primitiva” dell’accumulazione di capitale. Diciamola un po’ meglio, quando la quantità, cioè l’accesso al consumo di larghe masse, aveva il sopravvento sulla qualità (della vita) che appunto non è data solo dall’accesso al consumo (che anzi con il tempo è diventato un aspetto negativo e degenerativo delle società occidentali) ma da altri parametri: qualità del lavoro, qualità (e quantità) del tempo libero, del welfare, dell’istruzione, dell’ambiente, della sanità, delle relazioni umane e sociali, della sessualità, dello spazio in cui si vive, delle aree e delle abitazioni in cui si risiede, della viabilità, dei trasporti ecc. e anche della politica, o meglio dei sistemi democratici, cioè della partecipazione reale e della possibilità di contare realmente nei processi decisionali da parte dei cittadini. Penso di poter dire che per gli occidentali come te e come me (e come tutti quelli che hanno sottoposto a critica il modello capitalista-liberista-sviluppista-consumista) sono questi i parametri con cui misuriamo la qualità della nostra esistenza.
Sappiamo che il mondo è sempre andato avanti con tempi diversi, per ragioni oggettive, sia di ordine economico e sociale che storico e culturale. Ora, la Cina sta conoscendo oggi il suo “miracolo” (con tutte le peculiarità politiche e culturali del caso). Quello stesso “miracolo” che la nostra parte di mondo aveva già conosciuto (senza dimenticare che i “miracoli” avvengono anche al prezzo di lacrime e sangue, leggi sfruttamento parossistico di esseri umani, natura e ambiente) e che noi, in una fase più “matura” o già matura di tale sviluppo avevamo sottoposto a critica radicale.
Avevamo ragione? Secondo me sì. Ma mettiamo da parte per adesso questa questione.
Tornando all’oggetto e sempre semplificando fino all’inverosimile, cosa sta accadendo in Cina? Sta accadendo che quel processo di accumulazione e di modernizzazione capitalista che nel mondo occidentale si è verificato in un periodo di tempo relativamente molto lungo che va dai primi decenni del XIX secolo fino agli anni ‘80 del secolo scorso (e che ha oggettivamente trasformato la vita di centinaia di milioni di persone) si sta realizzando oggi. La novità (non certo di poco conto…) è che questo processo si sta verificando in quel paese in un lasso di tempo incredibilmente breve (e in forme acceleratissime) e senza il ricorso a politiche imperialiste e colonialiste che invece hanno caratterizzato tutta la storia dell’Occidente e senza le quali la “forma storica del capitalismo” occidentale non avrebbe potuto affermarsi e diventare dominante.
Qui il discorso si apre ulteriormente. La Cina non ha una storia e una tradizione di paese colonialista e imperialista. Lo diventerà o potrebbe diventarlo? Non è dato saperlo, al momento. Per ora non ne ha necessità perché la sua crescita economica è data ancora da un enorme mercato interno, dalla sua relativa autonomia per ciò che riguarda alcune risorse (vedi ad esempio le cosiddette “terre rare”, fondamentali per la tecnologia), dalla straordinaria alacrità e “senso confuciano del dovere” del suo popolo (e quindi da una incredibile capacità produttiva, in assenza di confitto sociale) e dalla sua abilità nel costruire relazioni economiche e commerciali vantaggiose con molti altri soggetti e stati pressochè in tutto il mondo. Aggiungo che per lungo tempo c’è stata anche una generale sottovalutazione della Cina da parte dell’Occidente e in particolare degli USA che li ha portati, in alcuni casi, a darsi la zappa sui piedi (penso ad esempio al fatto di delocalizzare in Cina diverse industrie, tra cui quelle di produzioni di armi e pezzi di ricambio e di tecnologia, oltre, naturalmente, al ben noto indebitamento finanziario). Del futuro non ci è dato sapere ma non possiamo, in linea teorica, escludere nulla a priori (sarebbe un atteggiamento ideologico…).
Altra questione. Di fronte alla critica per la quale la Cina sarebbe comunque una forma, anche se relativamente inedita, di capitalismo, i suoi sostenitori sostengono che così non è perché una buona parte delle aziende cinesi è di proprietà dello stato. E’ sufficiente questo per poter parlare di società socialista o “semi socialista”? A mio parere no. E qui faccio (e non ho nessun problema nel farlo…) una virata rispetto alla tradizionale relazione marxiana fra struttura e sovrastruttura. L’imperativo categorico, (quel famoso “gatto che non importa sia bianco o nero purchè acchiappi il topo”), la molla che spinge un miliardo e mezzo di cinesi a lavorare e produrre (e spesso a farsi sfruttare) dalla mattina alla sera – in una impresa privata o pubblica – è la prospettiva dell’arricchimento individuale e del consumo. Certo, declinati secondo le forme culturali confuciane che tu stesso hai descritto nel tuo post, ma sempre di quello si tratta.
Altra questione. Lo stato-partito – si dice (ed è vero) – guida questo gigantesco processo di accumulazione capitalistica facendo in modo che non deragli nelle forme caotiche e “anarcoidi” (liberiste…) proprie del capitalismo occidentale. La Politica (con la P maiuscola), insomma, ha (ancora) in Cina il prius sul mercato e sul capitale. La scommessa (quella che fanno i sostenitori, non solo marxisti, del “modello” cinese) è che il partito (stato), formalmente marxista-leninista, sarà in grado (o quanto meno questo si augurano) di indirizzare il paese in un futuro non meglio definito (ma i tempi sono molto lunghi, confuciani, appunto…) sulla strada del socialismo, o meglio, indirizzare questa gigantesca macchina di produzione capitalista verso una economia socialista (e quindi una società socialista). Naturalmente, se così veramente fosse, non potrei che esserne felice. Ma, allo stato, è solo una speranza o tutt’al più una possibilità. Io ho studiato che lo stato è la rappresentazione politica dell’ordine sociale dominante. Tradotto, lo stato non è un ente neutro ma lo strumento delle classi dominanti. Chi sono le classi dominanti in Cina? I lavoratori? La gigantesca classe operaia delle imprese sia pubbliche che private? La massa di lavoratori, per lo più ex contadini, che spostandosi dalle campagne alle città hanno anche perso una serie di diritti (in base ad una legge che lega tali diritti alla residenza nella regione in cui si vive)? La massa dei contadini dell’entroterra? Ho i miei dubbi. Ma li ho anche per un’altra ragione. Sappiamo che la realtà si fa nel suo farsi e non a priori. Il Partito Comunista in Cina non è una variabile esterna che sta al di fuori o sopra la società cinese, ma è parte integrante di essa. Per quale ragione oggettiva (non ideologica), il partito dovrebbe mantenere una sorta di purezza ideologica tale da consentirgli di imprimere una sterzata in senso socialista alla realtà? E’ molto più probabile che il partito (e lo stato), già componente organica della società, diventi lo strumento, il veicolo (cosa che a mio parere già è) di quel processo di sviluppo con quelle determinate caratteristiche. Che poi si definisca comunista ha una importanza relativa, soprattutto perché abbiamo già detto e mi pare che concordiamo sul fatto che il tratto distintivo della società cinese sia il confucianesimo e non il marxismo. Sempre pronto (e soprattutto felice) di ricredermi, sia chiaro.
In conclusione, mi limiterei per ora ad osservare lucidamente questo stupefacente (è il caso di dirlo) processo economico e sociale in corso in Cina, senza tirare le somme, senza fare il tifo, in un senso o nell’altro. Insomma, a sospendere il giudizio. Con la necessaria premessa che, comunque, stiamo parlando di un altro contesto e di altre categorie che in parte non sono le nostre (ma solo in parte perché il fanatismo produttivista e la corsa sfrenata al profitto e all’arricchimento individuale accomuna sia i capitalismi occidentali che quelli asiatici), che non possono essere universalizzate e che sicuramente non possono essere quelle di coloro che, qui ed ora, in Occidente, cercano di costruire faticosamente una via d’uscita, diciamo un punto di vista critico nei confronti dell’attuale sistema capitalista. E certo guardare alla Cina, in quest’ottica, non ci aiuta.