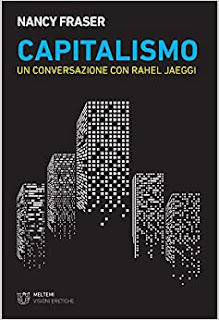Per i tipi di Meltemi, collana Visioni Eretiche, diretta da Carlo Formenti, è uscito nel 2019 questo impegnativo libro, sotto la poco usuale forma di un dialogo tra le due autrici. Il testo affronta l’ambiziosa impresa di fare il punto su come si possa sviluppare oggi una descrizione generale ed una critica al capitalismo. Le due autrici hanno una formazione piuttosto diversa: Nancy Fraser, settantadue anni, insegna scienze politiche e sociali e filosofia alla New School di New York, è Presidente della divisione est dell’American Philosophical Association, è stata a lungo condirettore di Constellations[1]. Dal punto di vista accademico e della influenza editoriale è certamente una donna di potere. Laureata nel 1969 e dottorata nel 1980, attraversa biograficamente tutta la parte ascendente del movimento libertario americano. Si specializza nel corso degli anni novanta nell’articolazione del concetto di “giustizia”, per il quale distingue due dimensioni reciprocamente separate, ma correlate: la giustizia distributiva e la giustizia del riconoscimento. Seguendo la traccia di questa concettualizzazione la Fraser è giunta al termine a sostenere che i movimenti identitari, concentrati sul riconoscimento di diverse identità di gruppo all’interno della società, hanno compiuto l’errore di trascurare l’altra dimensione correlata della distribuzione. Di qui è passata a criticare il femminismo liberale, come abbiamo visto in alcuni suoi recenti articoli[2], come in un libro del 2013[3] e nel recente manifesto “Femminismo per il 99%”[4]. Ad esempio, “Come il femminismo divenne ancella del capitalismo”, un articolo del 2013 su The Guardian ha scatenato un aspro dibattito nel quale si sono confrontate posizioni che identificavano l’eguaglianza di salari sul lavoro come lotta per la distribuzione e accuse di voler tornare agli anni settanta ed a un’impostazione marxista che ‘imprigiona la mente’. La provocazione della Fraser era rivolta al cosiddetto “femminismo della seconda ondata”, che, nella sua ossessiva concentrazione sulla critica del capitalismo statocentrico e welfarista del compromesso fordista (del quale criticava il welfare ‘patriarcale’ e ‘fallocratico’, e le organizzazioni connesse, sindacati inclusi) ha finito per farsi arruolare nell’esercito del suo nemico: il capitalismo neoliberale. O, secondo il linguaggio sessista della nostra “è diventato la sua ancella”. La critica avanzata era ambivalente, da una parte si trovavano le forme di solidarietà sociale e di potenziamento democratico, dall’altra il potenziamento dell’autonomia individuale e la promozione della scelta e avanzamento meritocratico. Alla fine il femminismo, nella critica della Fraser, si è reso disponibile ad essere utilizzato a portare acqua al neoliberismo. Gli ha conferito ‘carisma’. E non è stato un ruolo passivo, tutt’altro: il femminismo ha contribuito con tre idee importanti allo sviluppo dell’egemonia neoliberale: la critica al “salario familiare” ha finito per legittimare il ‘capitalismo flessibile’ che, in pratica, ha abbassato il salario a tutti (in modo che ora lavorano in due guadagnando spesso meno di quanto prima guadagnava uno). L’accesso delle donne in massa al lavoro ha scardinato il patto sociale del lavoro. Il secondo contributo decisivo è stato la critica (condivisa con tanta parte della ‘nuova sinistra’) all’economicismo marxista che ha finito per buttare bambino ed acqua. La politicizzazione del “personale” ha finito per andare nella stessa direzione in cui andava la critica neoliberale all’egualitarismo economico welfarista. Il terzo è stato l’attacco diretto al paternalismo dello Stato Sociale, che era esattamente quel che contemporaneamente faceva il neoliberismo per mercificare completamente la vita di tutti e tutte, esponendoli senza filtri alla durezza della vita. Si tratta della formazione, più in generale, di quel modello ideologico di grande potenza che qualche anno dopo, chiamerà “neoliberismo progressista” individuando in esso una sorta di paradossale ‘astuzia della storia’[5].
Invece Rahel Jaeggi, che ha giusto venti anni di meno, insegna filosofia pratica e morale all’Università Humboldt di Berlino. Si occupa di tipici temi filosofici, come l’antropologia filosofica, l’ontologia sociale e la teoria critica. Dal 1996 al 2001 è stata assistente di ricerca di Axel Honneth[6], l’ultima generazione della Scuola di Francoforte ed allievo di Jurgen Habermas. La sua tesi di dottorato è stata scritta sul poco tradizionale tema della “alienazione” (concetto da tempo espulso dall’accademia tedesca); si occupa di crisi del capitalismo e della democrazia ricevendo anche finanziamenti dalla Humanities & Social Change International Foundation di area Spd. Oltre alla tesi di dottorato, pubblicata con il titolo “Alienazione”[7], ed il libro in oggetto, ha pubblicato l’interessante “Forme di vita e capitalismo”[8].
All’avvio la conversazione riconosce che c’è un notevole ritorno in auge della critica del capitalismo causata dalla grave crisi sistemica in corso. La critica del capitalismo, come ricorda la Jaeggi, era cruciale per la teoria critica francofortese ma fu da questa in seguito abbandonata dopo l’estremo tentativo (ed al contempo la liquidazione) compiuto da Habermas in “Teoria dell’agire comunicativo”[9]. Da allora la teoria critica è diventata semplicemente l’ala sinistra del liberalesimo, sospendendo definitivamente il dubbio se si possa ancora domare il capitalismo. Ovvero si è adeguata a quel tentativo che per la Fraser è stato condotto dal liberalesimo novecentesco e dal post-strutturalismo francese di togliere di mezzo la problematica dell’economia politica.
Questa è la situazione. Per la Jaeggi, ma in questo in accordo con la sua collega, però non è solo un male perché il superamento dell’economicismo riduzionista delle teorie marxiste ha lasciato lo spazio per esplorare una “vasta gamma di questioni culturali, come il genere, la razza, la sessualità, e l’identità”. Tuttavia, per entrambe “ora bisogna ripristinare l’equilibrio”, per non perdere di vista l’importanza del lato economico nella vita sociale. Qui nasce l’approccio “sia/sia” della Fraser, ed il suo tentativo, per il quale spenderà le pagine centrali del libro, di “complicare, approfondire e arricchire quella critica [economica] incorporando [in essa] le intuizioni del pensiero femminista, della teoria culturale, del post-strutturalismo, del pensiero postcoloniale e dell’ecologia”[10]. Cercando, cioè, al contempo di non trascurare i motivi strutturali delle tendenze di crisi legate al decentramento della produzione industriale nel nord del mondo, all’ascesa della economia della conoscenza, alla centralità della finanza e dell’informatica ed in generale al lavoro simbolico. Si tratta, in altre parole, di un recupero di elemento di critica dell’economia politica condotto dall’interno del quadro logico ed assiomatico di un paradigma che oltre quaranta anni fa l’ha espulsa[11], accusandola di “economicismo”. Vedremo al termine se questo tentativo raggiunge il suo scopo.
L’obiettivo politico fondamentale è quello di cercare di costruire una piattaforma interpretativa che crei le condizioni per quella che la Fraser chiama una “alleanza controegemonica”, tra quelle forze politiche e sociali, che spesso si contrappongono, concentrate rispettivamente sulla distribuzione e sul riconoscimento. Da una parte i progressisti, sulla base materiale delle nuove professioni e del “capitalismo cognitivo”, hanno sviluppato nel tempo un’acuta attenzione all’emancipazione individuale ed al riconoscimento, dall’altra permangono e da tempo si rafforzano tendenze alla rivendicazione della protezione sociale. La stessa mossa con la quale si sono vendute come sensazionali ed esteticamente interessanti (Jaeggi parla di problemi interessanti, sexy e ‘bohemien’) i temi della sessualità oppressa, dell’identità non eteronormative o non cisgender, è quella che ha abbandonato i più grigi temi del lavoro e della classe. Temi fattisi “assolutamente noiosi”. Ma la desiderata alleanza tra emancipazione e protezione sociale passa per una presa di posizione anche verso la questione della ritirata della globalizzazione.
È molto netta la posizione delle nostre sul punto: la lampada della mondializzazione non può essere spenta. E quindi “la protezione sociale non può essere immaginata in un quadro nazionale”[12]. Sia perché ci sono sfide globali come il riscaldamento, sia perché il modello del capitalismo a gestione statale non riusciva comunque ad eliminare le ineguaglianze, oltre a sfruttare il terzo mondo. Funzionava trasferendo valore dalla periferia al centro. Non è dunque un modello (peccato che quello che è venuto dopo ha fatto peggio sotto tutti i profili, incluso lo sfruttamento imperialista[13]). Ripetendo quello che è uno dei più classici giri di pensiero del progressismo occidentale, le nostre ripetono insieme il mantra rassicurante (e identificante una tribù influente e vendicativa) che se il capitalismo “è, ed è sempre stato, una dinamica globale. [allora] Qualsiasi soluzione possiamo trovare, anche progettata per promuovere tipi di autonomia a livello nazionale o locale, dovrà essere sviluppata con questa dinamica globale in mente”. Nell’urgenza di difendersi dal rischio di debolezza ed intelligenza con il razzismo, xenofobia, misoginia, e dal populismo di destra che li rappresenta ed utilizza, ma consapevoli dell’insostenibile erosione in corso, il dilemma posto dalla discussione tra le due filosofe diventa se asserragliarsi a difesa delle conquiste libertarie, scontando anche un rafforzamento dell’alleanza con le forse progressiste (soluzione verso la quale inclina la Jaeggi). Oppure passare all’offensiva e cercare di costruire un nuovo blocco controegemonico. Il progetto che la Fraser chiama del “populismo progressista”.
“Combinando in un unico progetto un orientamento economico egualitario e a favore della classe lavoratrice con uno di riconoscimento non gerarchico e inclusivo, questa formazione avrebbe almeno una possibilità di combattere unendo l’intera classe lavoratrice: non solo le frazioni storicamente associate all’attività manifatturiera e all’edilizia, a cui i populisti reazionari e i tradizionalisti di sinistra si sono principalmente rivolti, ma anche quelle parti della classe lavoratrice più ampia che svolgono attività domestiche, agricole e di servizi – retribuiti e non retribuiti, in aziende private e in case private, nel settore pubblico e nella società civile -, attività a cui le donne, immigrati e persone di colore sono fortemente rappresentati. Corteggiando entrambi i segmenti, l’espropriato e lo sfruttato, un progetto populista progressista potrebbe posizionare il lavoro di classe, inteso in modo espansivo, come la forza trainante in un’alleanza che comprende anche i segmenti sostanziali di giovani, la classe media e lo strato professionale-manageriale”[14].
A questo progetto, così abbozzato (appunto sia/sia), la Jaeggi oppone la sensazione che la situazione politica sia mossa dal risentimento proprio verso il progressismo, causato non tanto dalla perdita di status e risorse, quanto dalla percezione di subire una insopportabile impotenza e per questo di essere moralmente in credito. Il ressentiment è, sotto questo profilo, un meccanismo di difesa, ma è anche una regressione. Ne consegue, come dice, che: “non serrare i ranghi con i neoliberali progressisti per difendere i risultati emancipatori ottenuti potrebbe presentare dei rischi”.
La divergenza fondamentale tra le due si situa su questo punto. Si tratta quindi di due diverse agende politiche. Una delle quali, la seconda, è una versione del “male minore”, l’abituale postura della sinistra riformista, che rischia di ridursi al ruolo di ventriloquo degli obiettivi liberali. Il punto della Fraser è che questo atteggiamento, che del resto abbiamo visto abbondantemente all’opera negli ultimi decenni, “fertilizza” il terreno sul quale cresce il risentimento. Alimenta esso stesso la rabbia, quindi è controproducente. Inoltre, e questo argomento ha decisamente peso, liberalismo e ‘fascismo’ non sono realmente opposti, ma restano due facce simmetriche se pur non equivalenti, delle medesime dinamiche sistemiche del capitalismo. Sono entrambi i prodotti di un capitalismo sfrenato che destabilizza mondi vitali e habitat. Forze liberali e controforze autoritarie sono legate reciprocamente, “così, lungi dall’essere l’antidoto al fascismo, il (neo) liberalismo ne è complice”, scrive la Fraser. Ovviamente questa diagnosi è possibile solo se si recupera uno sguardo sistemico e funzionale della situazione data, ovvero, come dice la nostra, se si riprende in mano l’economia politica. Nel momento in cui l’abbandoni e ti concentri sulla emancipazione individuale non è più visibile. Questo è, precisamente, ciò che è avvenuto.
Del resto, oggi il neoliberalismo è ancora al potere, ma ha perso egemonia. Quindi si sommano la crisi materiale e quella egemonica, e si aprono opportunità (e rischi). La prima relatrice vede soprattutto i primi, la seconda vede gli altri.
Ma ora andiamo con più ordine a cercare di capire di cosa parla il testo. Si parte con una breve discussione sulla definizione del termine “capitalismo”, etichetta che riassume cose abbastanza diverse come il “capitalismo competitivo” della prima parte del XIX secolo e il “capitalismo monopolistico” del XX secolo (o, nel linguaggio marxista, include diversi e successivi modi di produzione). Ci sono, insomma, molte varietà di capitalismo che è un fenomeno storico mai uguale a se stesso. Nel tentativo di individuare le caratteristiche fondamentali del capitalismo, dunque, la Jaeggi propone la costanza di due elementi:
- la proprietà privata dei mezzi di produzione, che a sua volta implica divisione di classe tra proprietari e produttori;
- la presenza dell’istituzione del mercato del lavoro libero;
- la dinamica dell’accumulazione del capitale basata su un orientamento interno all’espansione.
Una definizione classica, dunque. Una delle cose più rilevanti è che in questa formazione sociale è presente una spinta sistemica oggettiva verso l’accumulazione del capitale, ovvero all’autoespansione del valore. Con riferimento alla presenza di mercati la Jaeggi sottolinea che si tratta di una relazione intrecciata e complicata, in quanto il capitalismo è molto più di una “società di mercato” e i mercati sono esistiti ben prima dello stesso. Altrettanto, sostiene, “potremmo pensare a una società socialista che include meccanismi di mercato”[15].
Di qui la lettura dell’americana procede a indicare nella mossa critica di Marx nei primi capitoli de “Il Capitale”, l’individuazione della forma di merce come caratteristica del capitalismo in quanto intreccio di mercati, ma, più in profondità della creazione del valore nel laboratorio della produzione. Ovvero la comparsa del valore come risultato dello sfruttamento (dell’appropriazione di plus-valore). Quindi Marx sarebbe incline a “sostituire l’attenzione allo scambio di mercato tipica dell’economia politica borghese, con un più profondo e critico focus sulla produzione”.
Mettendo da parte questa questione, la discussione passa a concentrarsi sul problema dell’esistenza sistematica di aree che sono escluse dal mercato, sono ai margini del circuito delle merci, agiscono sulla base di altre metriche. Una condizione che spinge, o trattiene, masse enormi nell’informale, nel non-mercificato. L’interpretazione di questa condizione che il testo propone è che anche qui si tratta di una dimensione sistemica del capitalismo. “Una caratteristica insita nel DNA del capitalismo – per la Fraser –. In effetti la ‘coesistenza’ è un termine troppo debole per cogliere la relazione tra gli aspetti mercatizzati di una società capitalistica di mercato e quelli non mercatizzati. Un termine migliore potrebbe essere ‘embricatura funzionale’ o, ancora meglio e più semplicemente, ‘dipendenza’”. In sostanza, come sostiene Polanyi, la società non può essere merce e i mercati dipendono da relazioni sociali non mercatizzate che forniscono le condizioni di possibilità psicologiche e materiali. Se la società fosse interamente mercatizzata non funzionerebbe. O renderebbe impossibile trasmettere un ethos ad essa necessario. Se accadesse, in altre parole, si creerebbero quelle che la Jaeggi, spostandosi sul piano normativo, chiama “gravi contraddizioni immanenti”.
E proprio in questo punto viene inserito il focus tematico femminista della riproduzione, intesa in modo molto largo come tutte quelle forme che “producono e mantengono legami sociali”, e consistono nella ‘tutela’, nel ‘lavoro affettivo’, nella formazione di soggetti umani come esseri incarnati e come esseri sociali. Qualcosa che forma il loro habitus e la loro sostanza socio-etica nella quale si muovono. Si tratta, cioè, del lavoro di socializzazione dei giovani, della costruzione di comunità e di produzione e riproduzione di significati condivisi, di disposizioni affettive e orizzonti di valore che sostengono la cooperazione sociale. Il punto è che, parla la Fraser, “nelle società capitaliste molta (anche se non tutta) quest’attività continua al di fuori del mercato – nelle famiglie, nei quartieri, nelle associazioni della società civile e in una serie di istituzioni pubbliche, tra cui scuole e centri di assistenza all’infanzia e agli anziani”[16].
In questa formulazione così ampia si tratta di una presa di posizione indiscutibilmente corretta. Ma, se pure alcune di queste attività indispensabili e non mercatizzate (non mercatizzabili) sono comparativamente svolte in misura maggiore da donne, nessuna è specificamente ed esclusivamente femminile. Non solo le donne creano e mantengono i legami sociali, svolgono ‘lavoro affettivo’, formano esseri umani e li socializzano, costruiscono comunità e producono significati, disposizioni affettive e orizzonti di valore. Non solo le donne sostengono la cooperazione sociale.
Ma, e in questo ovviamente la mia distanza dal femminismo, io dico di più: non lo fanno principalmente le donne, e non lo fanno maggiormente le donne. Ovviamente lo fanno sia le donne sia gli uomini, e, naturalmente, lo fanno diversamente. Rivendico, in altre parole, anche come padre oltre che come essere sociale e buon amico, parte responsabile di una comunità umana, la mia capacità, pur non essendo donna, di produrre e mantenere legami sociali, di amare e essere capace di tutela dei più deboli e dei vicini e parenti, di contribuire per la mia parte a formare soggetti umani come esseri incarnati e come esseri sociali. Rivendico la mia capacità di comprendere e rispettare l’habitus nel quale viviamo e la sua sostanza socio-etica. Di essere parte della socializzazione dei giovani, della costruzione di comunità e di produzione e riproduzione di significati condivisi, di disposizioni affettive e orizzonti di valore che sostengono la cooperazione sociale.
Ma torniamo al testo. In genere il femminismo per “riproduzione” intende strettamente l’allevamento dei nuovi esseri umani come forza lavoro (per cui, schematicamente, se non ci fossero le madri a tutta evidenza non ci sarebbero i figli, non crescerebbero, e dunque non ci potrebbero essere lavoratori). Una funzione che nella prospettiva tradizionale del cosiddetto “salario familiare”[17] è femminilizzata. Se fosse tutto qui il femminismo sarebbe una battaglia di retroguardia, in quanto le condizioni di riproduzione sociale per l’accumulazione lo hanno superato da tempo. Come abbiamo visto è tramontato come modello normativo e socialmente dominante con l’insorgere dell’accumulazione flessibile nella quale si è passati ai due salari e quindi alla ripartizione del lavoro su entrambi i ruoli. La Fraser propone perciò una versione molto allargata del termine, quella sopra schematizzata, al fine di rendere ancora possibile la critica femminista in un mondo nel quale in linea di principio tutti lavorano (se pure male). Un mondo nel quale sembra si sia riprodotta quella condizione denunciata da Angela Davis in “Donne, razza e classe”[18] per la quale donne e uomini erano del tutto equivalenti, in tutti i lavori, perché visti dai padroni di schiavi dei paesi del sud solo come forza lavoro.
Da una parte la ‘riproduzione’ sociale comprende ora in senso larghissimo la creazione, socializzazione e soggettivazione degli esseri umani, in tutti i loro aspetti. Quindi “anche la realizzazione e il rifacimento della cultura, delle varie aree dell’intersoggettività in cui gli esseri umani sono inseriti – le solidarietà, i significati sociali e gli orizzonti di valore nei quali e attraverso i quali vivono e respirano”. Dall’altra resta appannaggio femminile. In pratica, detto in altro modo, per la visione sessista della nostra le donne sono esseri umani completi e gli uomini solo forza lavoro. Si tratta chiaramente, nello sforzo di restare femminista riconoscendo al contempo che la lotta allo stato fordista è un residuo e un rischio, di gettare una rete così ampia che la Jaeggi, con una certa malizia che ricorrerà qui e lì nel lungo testo, gli chiede se vuole incorporare nella prospettiva femminista anche tutta la problematica foucaultiana della creazione del soggetto e quella bourdieusiane dell’habitus, insieme ai neohegeliani con il termine sittlichkeit.
Quasi, o forse proprio, senza accorgersi che la collega la sta accusando benevolmente di fare minestroni di difficile digeribilità la nostra conferma di “stare stendendo deliberatamente un’ampia rete”. Tanto ampia che, aggiungo, oltre ai divergenti pensatori citati ci sarebbe appunto da chiedere che c’entri il femminismo in sé. Ma per lei si tratta di costruire quella che chiama una “concezione espansa” del capitalismo per fare spazio e a tutte queste tradizioni interpretative. La divisione tra riproduzione sociale, in questo senso totalizzante, e la produzione di merci sarebbe quindi fondamentale per il capitalismo, e contemporaneamente ne sarebbe un artefatto (cosa che storicamente può essere sostenuto in modo arduo). Ma, di più, “questa divisione è completamente di genere, essendo la riproduzione associata alle donne e la produzione agli uomini”. Per l’appunto le donne sono esseri umani completi e gli uomini solo forza lavoro. Nel senso che sono forza lavoro entrambi (come era per gli schiavi), ma le donne in più creano anche la società.
O è così, o in questo passaggio, sul quale la Jaeggi ha una delle sue divergenze, in effetti la Fraser slitta inavvertitamente indietro sulla sua stessa definizione. La riproduzione e la dipendenza sarebbero ricondotte all’assenza del salario, e quindi alla base della cura dei figli. La più larga riproduzione sociale e dei significati ne diventa un effetto derivato (come l’intera umanità, in effetti). Questo che è il nodo centrale, costantemente ripreso allo stesso livello di incoerenza interna in tutti i suoi testi, suona misandrico (o, forse, solo espressione di una comunità di trauma). L’affermazione è contemporaneamente superata dai tempi (ormai la famiglia standard, quando non è monocomposta è bisalariata) e limitata ad una dimensione importante, ma non ampia come quella descritta nelle pagine precedenti. Infatti, se si può ben dire che dove permane la condizione per la quale il “salario familiare” è appannaggio di un solo partner, come nella forma socio-economica fordista, l’altro è in condizione strutturale di dipendenza (come mi ripeteva sempre mia madre, che infatti ha sempre lavorato a volte guadagnando più di mio padre), tuttavia è palese che la capacità di sostenere materialmente la riproduzione non è diversa se la somma necessaria viene da un salario o da due. Infatti, quando, nella forma socio-economica “emancipata” nella quale viviamo, il saggio di sfruttamento è cresciuto dal momento che i due salari sommano il vecchio, il sostegno materiale si è degradato. La stessa Fraser lo ricorda sotto l’etichetta di “fine della cura”[19].
La seconda dipendenza del capitalismo da qualcosa che non è in grado di riprodurre si manifesta rispetto alla più ampia natura non umana. Una critica che la Jaeggi trova romantica: per lei non bisogna mai dimenticare che è bene non essere più dipendenti dalla natura.
Infine, ed in terzo luogo, il capitalismo dipende dal potere pubblico e dallo Stato per garantirsi le condizioni legali di esistenza, il quadro legale. Ma è anche connesso e dipendente dalle logiche centro-periferia imperialiste e dall’oppressione razziale. Parte integrante della società capitalista è quindi la dominazione di genere e razziale. Ovvero l’espropriazione che è resa possibile dall’assenza di protezioni politiche e dallo squilibrio di forza e potere. Tutte queste forme di espropriazione e di appropriazione senza controvalore sarebbero necessarie all’esistenza stessa del capitalismo che quindi dovrebbe, per esistere, allargare sempre l’area di espropriazione. Una idea che risale a Luxemburg[20].
Ma nella versione proposta dalla Fraser tutto si riconduce ad un piano invero piuttosto contraddittorio, anche se a suo dire mai pensato dal marxismo ortodosso: per garantirsi l’espansione progressiva, e in via di principio illimitata, dell’appropriazione privata del plusvalore i proprietari del capitale devono ottenere mezzi produttivi ad un prezzo inferiore alla sua riproduzione. Ciò si verifica con il (sovra)sfruttamento della natura e con il soggiogamento di popolazioni razzializzate. “I tassi di profitto salgono nella misura in cui il capitale è in grado di rendere gratuiti tali processi, evitando responsabilità per il loro sfruttamento”[21]. E contenendo anche i costi di riproduzione della forza lavoro normale, ottenendo un dividendo indiretto (dall’imperialismo e dalla distruzione delle risorse naturali). Una formulazione certamente presente in tutta la tradizione marxista (a partire dalla critica dell’imperialismo di Lenin, e dalle analisi dell’ultimo Engels, e poi da tutta la tradizione delle lotte terzomondiste cui, pure, in varie occasioni si richiama). Al contempo una formulazione che retrocede significativamente rispetto al livello di distinzione ed analisi dello stesso Marx e della tradizione che ne deriva. In senso stretto non si può ottenere un bene qualsiasi (e tanto meno la forza lavoro) ad un prezzo “inferiore alla sua riproduzione”, perché si distruggerebbe. Persino il selvaggio sovrasfruttamento degli schiavi neri, prima della interruzione del traffico che ne sostituiva i frequenti morti, era condotto al prezzo della riproduzione, se con questo termine si intende, coerentemente con una definitoria economica, il totale dei prezzi derivanti dall’insieme dei meccanismi volti a riportare il giorno dopo, ed i successivi, la stessa quantità di forza lavoro in campo (nell’esempio era il prezzo delle misere abitazioni, dell’insufficiente cibo e legna, o vestiti, e il costo necessario per sostituire i deceduti). Ma, qui l’argomento ben più sofisticato della Luxemburg, in un sistema chiuso la mera riproduzione del capitale (e non della forza lavoro) presume il realizzo nella circolazione, e questo tende alla riproduzione stazionaria. La crescita resta inspiegata. È il problema del passaggio dalla cosiddetta “riproduzione semplice” alla “riproduzione allargata” (estensione della produzione di plusvalore).
La Fraser sembra affastellare definizioni e frammenti di argomentazione senza far capire come risolve i sottostanti problemi con un approccio additivo e alquanto eclettico.
Il capitalismo è per lei qualcosa come un ordine sociale istituzionalizzato ed una forma di vita che non ha un vero e proprio dentro o fuori, ma dispone di una sua topografia sociale. Una forma storicizzata, nella quale elementi diversi hanno proprie normatività e ontologie sociali. Capaci di sviluppi “relativamente autonomi” che non sono solo, o semplicemente, “riflessi” degli sviluppi economici e tecnologici. Possono esserne influenzati, ma possono anche influenzarli. Le sfere della riproduzione, dell’ambiente e natura, del potere, sarebbero così viste come semi-indipendenti dalla produzione di merci e dalla relativa circolazione e valorizzazione, e, al contempo, sfruttate da questa per la sua esistenza e stabilità. Quel che cerca di fare la Fraser, che guida questa parte della conversazione, non è solo di salvare la politica del riconoscimento e delle identità nella quale si è formata, associandola all’economia politica che vuole recuperare, ma con una specie di gioco di prestigio anche sostenere al contempo che nella dichiarazione del ruolo necessario della riproduzione, della natura e dello Stato esista una vera novità rispetto al marxismo.
Nel suo ordine di discorso, che è più una focalizzazione, le crisi nel sistema capitalistico non sorgono tanto nella sua meccanica produttiva (la tendenza alla caduta del saggio di profitto, ad esempio), quanto al suo confine con le condizioni non economiche di possibilità. Ne derivano tendenze di crisi che chiama “(quasi) polanyiane”. Detto in altre parole:
“l’economia del capitalismo risulta anche da una relazione di negazione nei confronti delle sue condizioni sottostanti. Essa ne sconfessa la propria dipendenza trattando la natura, la riproduzione sociale e il potere pubblico come ‘doni gratuiti’, che sono inesauribili, privi di valore (monetizzato) e di cui ci si può appropriare ad infinitum senza nessuna preoccupazione per il loro rifornimento. Di conseguenza, la relazione è potenzialmente contraddittoria e incline alla crisi, perché l’incessante deriva verso l’accumulo in continua espansione destabilizza le condizioni sottostanti da cui dipende la dinamica in primo piano. Tutto sommato si tratta di una relazione di divisione-dipendenza-disconoscimento. E questa è una fonte interna di potenziale instabilità, una ricetta per crisi periodiche”[22].
Una formulazione inconsapevolmente perfettamente marxiana, in ogni sua parte. Se non che compie il percorso inverso rispetto a quello di Marx, che procedeva verso l’astrazione e la ricerca della relazione essenziale, mentre la Fraser cerca di mettere sullo stesso piano tutto, nella logica sia/sia prima enunciata. Quello che Jaeggi chiama “un vocabolario olistico per spiegare come le sfere interagiscono in modo diverso in tempi diversi”. Sarà olistico, ma è anche confuso.
Nel ricostruire quindi l’evoluzione storica dei modelli capitalisti (mercantilista, liberale ottocentesco, e “a gestione statale” novecentesco) si giunge infine alla descrizione della crisi degli anni settanta, crogiolo della sua formazione, e qui la settantaduenne Fraser racconta alla più giovane collega che il capitalismo a gestione statale, pur avendo stabilizzato per alcuni decenni le tendenze di crisi di riproduzione del capitalismo, è al termine “incappato nelle sue stesse contraddizioni, sia economiche sia politiche”. Precisamente che i “salari crescenti e i generalizzati incrementi della produttività, combinati a minori tassi di profitto nell’attività manifatturiera del centro” hanno alla fine “suggerito la necessità di nuovi sforzi da parte del capitale per liberare le forze del mercato dalla regolamentazione politica”. Ciò che colpisce di questa scheletrica ed economicamente confusa descrizione (se salgono sia i salari sia la produttività perché calano i tassi di profitto?) è il modo in cui continua, con l’associazione che propone immediatamente: “sono così esplosi movimenti globali di sinistra radicale per sfidare le oppressioni, le esclusioni e le predazioni su cui poggiava l’intero edificio”.
Insomma, il capitalismo è in difficoltà quanto alla riproduzione del capitale (ovvero ha difficoltà determinate dalla crescita dei salari oltre l’incremento della produttività -quindi salari reali- a danno della quota profitti), e risponde con la deregolamentazione che, però, viene aiutata dalla sinistra radicale la quale attacca sincronicamente lo stesso bersaglio. Insomma, sembra dire la Fraser, una sinistra che lavora oggettivamente per il re di Prussia.
Di fatto da allora il capitalismo finanziarizzato ha revocato quelle protezioni, introducendo però ancora più oppressioni, esclusione e predazioni. La crisi a questo punto si presenta al capo opposto del pendolo marxiano: riducendo la quota salari (anche grazie all’estensione della concorrenza tra lavoratori, causata sia dalla femminilizzazione della forza lavoro sia dalla sua razzializzazione) rispetto alla produttività la quota profitti è cresciuta costantemente, con essa l’accumulazione al vertice della piramide sociale. Ma in questo modo la riproduzione della forza lavoro è sfidata (“fine della cura”[23]) e la carenza di domanda, come proponeva già la Luxemburg centodieci anni fa, rende difficile il “realizzo” del plusvalore estratto. Di qui la finanziarizzazione e, al termine del ciclo, la crisi contemporanea.
Si potrebbe dire che la socialdemocrazia ha creato i propri becchini. Tutte le lotte del movimento sociale degli anni sessanta, dice la Fraser che le ha vissute (quelle per la decolonizzazione e l’uguaglianza razziale, il femminismo della seconda ondata), hanno “valicato i confini del buonsenso socialdemocratico. Nel tempo, le loro sfide hanno finito per convergere non solo tra di loro, ma anche con quelle di un nascente partito ‘neoliberale’, determinato a strappare le ‘forze del mercato’ al controllo statale e a globalizzare l’economia capitalista. È stato questo duo tra movimenti sociali emancipatori e neoliberalismo che ha distrutto l’egemonia della socialdemocrazia e alla fine il regime del capitalismo di stato”[24]. È a questo che coloro i quali hanno meno di quaranta anni debbono una vita intera di precariato, indipendentemente siano uomini o donne.
La critica di sinistra allo stato sociale è parte di questo movimento. Quella alla società disciplinare, al potere amministrativo, alle tendenze alla normalizzazione dello stato sociale, alla burocratizzazione ad esso connaturata. Con il linguaggio di Habermas, che esprime una particolare versione di quella costellazione, la critica alla “colonizzazione del mondo vitale” (da parte del ‘codice potere’). La risposta è stata di delegittimare ogni intervento pubblico (anche quando era diretto contro lo strapotere del capitale) per rifugiarsi nel privato o nel privato-collettivo: “organizziamoci in movimento sociali; occupiamoci dei nostri problemi”, razza, sesso, orientamenti. Puntiamo ad essere riconosciuti come individui e per i nostri desideri. Si è perso di vista il potere del capitale privato, delle grandi concentrazioni private di capitale e queste sono state leste ad approfittarne. In parte è stato un effetto della diffusione della ricchezza, dello sprawl urbano, persino (con la disintegrazione delle preesistenti unità sociali dei quartieri operai in villette diffuse che incoraggiano una visione individuale dell’abitare).
L’immaginario socialdemocratico, concentrato sulle questioni salariali (nelle quali aveva appunto raggiunto un decisivo successo) e delle condizioni di lavoro non era più adatto a dare rappresentazione a queste nuove energie e strutture del sentire sociale che scaturivano dalle donne con istruzione universitaria e di classe media, le quali rivendicavano riconoscimento, oltre che dalla cultura di massa e giovanile. La nuova sintesi sarà quindi un insieme sincretico di critica al paternalismo burocratico, al disconoscimento individuale e, da parte neoliberale, all’assistenzialismo. L’era neoliberale vive di questo ethos che è stato creato anche dai movimenti della sinistra radicale. Quella che la Jaeggi, che concorda, chiama “una bella astuzia della storia”.
Lo scopo della costruzione addizionale della Fraser è, secondo la Jaeggi in quella che suona come una garbata obiezione (il registro è spesso di questo tenore, la filosofa tedesca avanza obiezioni radicali alle tesi dell’americana, ma nascondendole in un velo di cortesia accademica), mettere insieme molte e diverse strutture di dominio e oppressione correndo il rischio di riprodurre forme gerarchiche non sufficientemente argomentate e senza chiarire bene come le istanze di dominio ed oppressione funzionano insieme. L’impressione che la tedesca trae è che nella vecchia polemica tra marxisti e femministe sulla cosiddetta “teoria del sistema duale” (circa la questione della ‘contraddizione primaria’, rappresentata dal capitalismo) la Fraser scelga di stare con i marxisti. La risposta è: “rifiuto categoricamente la visione delle contraddizioni primaria e secondaria”. Vediamo:
“l’intera teoria del disvelamento di ulteriori ‘dimore nascoste’, oltre a quella su cui si è concentrato Marx, intende mostrare che le forme di oppressione ospitate (subordinazione di genere e razziale, imperialismo e dominio politico, saccheggio ecologico) sono caratteristiche strutturali integrate della società capitalista – profondamente radicate quanto sfruttamento e dominio di classe. La mia argomentazione intende confutare la visione secondo cui solo la classe sarebbe strutturale. E farei lo stesso nei confronti di chiunque cercasse di installare qualsiasi altra istanza in quella posizione privilegiata, definendola ‘contraddizione primaria’.
Tuttavia – ed ecco il mio secondo punto – respingo anche gli approcci pluralisti o additivi, come la teoria del sistema duale (o triale). Lungi dal concepire il capitalismo, il patriarcato e la supremazia dei bianchi come ‘sistemi’ separati, che in qualche modo di combinano misteriosamente, io sto proponendo una teoria unificata, in cui tutte e tre le modalità di oppressione (di genere, ‘razza’, classe) sono strutturalmente radicate in una singola formazione sociale – nel capitalismo in senso ampio, concepito come un ordine sociale istituzionalizzato. E, a differenza delle teorie dell’intersezionalità, che tendono ad essere descrittive, focalizzate sui modi in cui le posizioni dei suddetti soggetti si incrociano l’una l’altra, il mio discorso è esplicativo. Guardando dietro queste posizioni, all’ordine sociale che le genera, io identifico i meccanismi istituzionali attraverso cui la società capitalista produce genere, razza e classe come assi trasversali del dominio”[25].
Ciò implica che talvolta, storicamente e localmente (ad esempio ora nelle società occidentali avanzate) il capitalismo, in alcune sezioni (ad esempio avanzate), possa anche fare a meno delle divisioni di genere o razza. Tutto dipende dal regime di accumulazione in vigore, “da come e dove i suoi limiti costitutivi sono stati tracciati, nella portata distruttiva della sua matrice istituzionale e nella misura in cui stanno sondando alternative”. Come propone di considerare la Jaeggi, quindi, è possibile che un dato ordine razziale o sessuale possa rivelarsi ostile ad alcuni settori del capitale (e “qualcosa di simile potrebbe essere in corso oggi”), ma non è corretto inferirne, per la Fraser, che il capitalismo in quanto tale possa oggi fare a meno della gerarchia di genere o razziale simpliciter.
Proseguendo la sua decostruzione a questo punto la Jaeggi inferisce che nei termini del discorso dell’americana il capitalismo sarebbe caratterizzato, in quanto modello e quindi al di là delle sue incarnazioni storiche o geografiche, dal fatto di avere bisogno di soggetti di sfruttamento ed espropriazione (i due termini essendo mal definiti). Dunque, che “non esiste assolutamente alcuna ragione [entro la teorizzazione dell’anziana filosofa] per la quale [gli sfruttati] debbano essere definiti lungo linee sessualizzate o razzializzate”. Quindi l’ordine di genere e di razza descrivono “semplicemente i modi empirici con cui espropriazione e sfruttamento sono stati organizzati”. A questa obiezione la nostra risponde che “ogni forma di capitalismo separa la produzione dalla riproduzione, lo sfruttamento dall’espropriazione”. Dove, secondo la sua imperfetta definizione, la seconda si caratterizza perché esso non si fa carico dei costi di riproduzione (come abbiamo già detto in senso proprio ciò significa che è espropriazione il genocidio degli Inca sudamericani, ma non lo è la schiavitù perché il padrone di schiavi in genere si assicura della riproduzione in qualche modo). Queste divisioni sarebbero, cioè, costitutive della società capitalista. E sarebbero esistite a partire da questo. Come dice, “se il capitalismo richiede che la produzione e lo sfruttamento vengano separati dalla riproduzione e dall’espropriazione, rispettivamente, e se richiede che queste ultime funzioni vengano assegnate a classi di persone separate e distinte, espressamente designate a tale scopo, allora il capitalismo non può essere distaccato dall’oppressione di genere e razziale”[26]. A questa riaffermazione definitoria, contraddittoria nei termini della sua stessa ricostruzione storica, ed in fondo dogmatica, senza la quale la Fraser a tutta evidenza non potrebbe più dirsi “femminista”, ricadendo nel novero delle pensatrici semplicemente “socialiste”, la Jaeggi insiste spietatamente.
Chiede, infatti:
“tu dici che il capitalismo separa la storia in primo piano, quella della produzione di merci, da quella sullo sfondo, quella dell’espropriazione e della riproduzione sociale. Dici anche che il sessismo ed il razzismo sono intrinseci al capitalismo fintanto che esso assegna le funzioni della storia sullo sfondo a popolazioni appositamente designate, che di conseguenza saranno razzializzate e femminilizzate. Ma lasci aperta un’altra possibilità. E se il capitalismo non richiedesse questa seconda condizione? E se mirasse a espropriare e ‘riproduttivizzare’ quasi tutti, esigendo manodopera in quelle dimore nascoste dall’intera popolazione che non possiede capitale, oltre a ciò che esso già richiede loro attraverso lo sfruttamento del lavoro salariato? Non è uno scenario possibile? E se lo fosse, il risultato non sarebbe un capitalismo non razzista, non sessista?”[27].
Messa alle strette la Fraser ammette espressamente che si tratta de “il nocciolo della questione”.
Lo scenario descritto è infatti “logicamente possibile” (e dissolve come lotta di retroguardia, se pure a volte necessaria, l’intero femminismo). Ma per la Fraser “possiamo escluderlo per tutti gli scopi pratici”. Il capitalismo finanziarizzato di oggi (ovvero quello che segue al modello del capitalismo sostenuto dallo stato precedente) è “un regime di espropriazione universalizzata”, e non solo le popolazioni razzializzate ma anche la maggior parte dei “bianchi” ora “guadagnano salari che non riescono a coprire interamente i costi di riproduzione”, e sono in balia senza protezioni di aggressioni date da usura predatoria e precariato. Inoltre, non solo gli uomini, ma anche le donne, devono vendere la propria forza lavoro a tempo pieno. Eppure, scrive, “il capitalismo attuale è tutt’altro che postrazzista o postsessista”. Esiste ancora una sproporzione.
La risposta è indicativa e importante: ad una obiezione di tipo concettuale e definitorio, estratta dai termini stessi posti dal discorso della Fraser, questa risponde con un’ammissione e con lo spostamento del punto sul piano empirico; ancora oggi proporzionalmente le popolazioni razzializzate sono più povere, mediamente, e molte donne devono sopportare l’onere di lavorare e di fare i doppi turni per caricarsi anche il lavoro domestico. Insomma, dato che riconosce, sia pure a denti stretti, che non si tratta di una necessità organica, ma di una permanenza residua, ne deriva che non sarebbe tanto “il capitalismo” a richiederlo (dato che questo richiede solo lo sfruttamento e non determina specifici sfruttati), quanto, piuttosto, la consuetudine ed il peso della tradizione. È un residuo, e condanna a ben vedere l’intero femminismo a lotta di retroguardia (se pure localmente ed in alcune circostanze necessaria).
Sottolineiamo ancora una volta un’implicazione dell’affermazione che tutti “non riescono a coprire interamente i costi di riproduzione”: si tratta di una carenza concettuale e di un abuso definitorio. Il termine “riproduzione” ha infatti un fondo biologico, ma qui piuttosto è utilizzato nel senso della riproduzione dello stile di vita adeguato alla media sociale. Ovvero di quello che Engels chiamava la “convenzione sociale”. Tuttavia, a ben vedere, c’è anche un’aggiunta rispetto a questa accezione: la riproduzione dello stile di vita che si lamenta essere impossibile con i salari mediamente praticati è quello borghese. In altri termini, è palese che la riproduzione meramente biologica è garantita dai salari (che, altrimenti, la società collasserebbe immediatamente nelle rivolte del pane), ma quella che non è uniformemente garantita è piuttosto la disponibilità dei mezzi monetari di spesa per dotarsi del set di merci e servizi ritenuti necessari per una vita “dignitosa”. Precisando che con tale termine, per definizione relativo, si intende una vita conforme allo stile della media borghesia novecentesca. O, più brutalmente, che si è alle prese con un processo di pauperizzazione al quale si somma una persistente dipendenza, dissimmetricamente distribuita, tra maschi e femmine (per cui sono le seconde che, mediamente, sono più facilmente in condizione di deprivazione e dipendenza). Insomma, il discorso oscilla intorno alla medesima posizione che viene criticata.
L’azione politica si rivolge quindi ed espressamente, da una parte, “contro gli intendimenti tradizionali del socialismo”, in quanto la Fraser ritiene che un focus esclusivo (che il socialismo non ha mai praticato, a dire il vero) sullo sfruttamento e la produzione non può emancipare i lavoratori di ogni colore o genere; dall’altra, contro le femministe liberali e contro gli antirazzisti, propone di considerare che un focus esclusivo su discriminazione, ideologia e legge non è la strada giusta per superare razzismo e sessismo.
Nel primo caso, è necessario anche indirizzare l’azione contro l’espropriazione e la riproduzione a cui lo sfruttamento e la produzione sono in ogni caso legati. Nel secondo, è necessario anche sfidare l’ostinato nesso del capitalismo tra espropriazione e sfruttamento, tra riproduzione e produzione. Seguendo questa via (che, continuo a dire, è perfettamente presente nella tradizione marxista, con maggiore rigore concettuale), si accederebbe ad un radicalismo più profondo “finalizzato alla trasformazione strutturale della matrice sociale complessiva”.
Cambiando argomento il testo si concentra sulla critica al capitalismo. Quale è il punto: esso è un sistema disfunzionale, che è costantemente incline alle crisi? O, piuttosto, un sistema moralmente sbagliato perché fondato sullo sfruttamento? Una vita, terza possibilità, fondata sul capitalismo è eticamente malvagia, impoverita, priva di senso ed alienata?
La critica marxiana è imperniata su tutte e tre le dimensioni. La prima è molto evidente e nota, il capitalismo non è orientato alla soddisfazione dei bisogni umani, quanto alla crescita dell’accumulazione per la quale ha una tendenza allo sviluppo delle forze produttive intrinsecamente contraddittorio (su una linea di critica in fondo non dissimile da quella della “riproduzione” avanzata dalla Fraser, se il termine non si intende in senso individuale ma sistemico). Ma questa critica poggia sempre internamente su criteri di tipo normativo e politico. La seconda critica si muove esplicitando questo livello. Ma qui non basta dire che il capitalismo crea ineguaglianze ingiuste, o non motivate adeguatamente, perché bisogna stabilire anche quali sono presenti specificamente di esso. Una ineguaglianza, la semplice esistenza della ricchezza e della concentrazione di potere, che fosse tale dal tempo delle prime civiltà stanziali sarebbe una linea di critica ben povera, al capitalismo. Per questa ragione la critica è in realtà eticamente orientata, legge il capitalismo nella sua interezza come una modalità distorta di vita, ed, inoltre un ostacolo alla ‘libertà sociale’[28].
Per le autrici la visione proposta di capitalismo come sistema sociale ed istituzionale, e quindi anche come forma di vita e quadro di soggettivazione, e non solo come sistema economico ha una conseguenza nella concettualizzazione delle lotte. Mentre nella teoria marxista, sorta alla metà dell’ottocento e sviluppatasi fino alla seconda metà del novecento, la forma che serbava la maggiore potenzialità di emancipazione delle lotte era la cosiddetta “lotta di classe”, ovvero la lotta per l’eliminazione dello sfruttamento e la divisione della società in ‘classi’, ora per la Fraser sono centrali le “lotte di confine”. Questo discorso è compreso dalla sua autrice come “diverso da quello ampiamente associato al marxismo”. Secondo la sua visione “il capitalismo, concepito come qualcosa di più grande di un sistema economico, rende visibile e intelligibile uno spettro più ampio di contestazioni sociali di quanto non facciano i paradigmi ortodossi”[29]. Si tratta, cioè, di lotte tra una divisione di un primo piano ed uno sfondo, “divisione”, “dipendenza”, “disconoscimento”. Le lotte contro il razzismo, l’imperialismo e il sessismo non sarebbero, dunque, manifestazioni di “contraddizioni secondarie”.
La cosa appare realmente nuova alla nostra soprattutto in quanto la sua visione espressa di quel che chiama “marxismo ortodosso” è piuttosto ridotta. Con le sue stesse parole: “per i marxisti ortodossi, la lotta di classe è centrata sul conflitto tra lavoro e capitale, dove per lavoro si intende strettamente quello salariato, specialmente nel contesto delle fabbriche industriali”. Quindi le uniche lotte realmente emancipative sarebbero quelle che appaiono sui “luoghi di produzione”, dove “le due parti si trovano faccia a faccia”. Questa posizione sarebbe problematica “perché esclude le battaglie per il lavoro non salariato e soggetto a espropriazione. Queste ultime non vengono considerate lotte di classe, proprio come coloro che svolgono questo tipo di lavoro non vengono ritenuti ‘lavoratori’”. Invece dovrebbero essere considerate “di classe”, perché sostengono il lavoro salariato e alimentano e riproducono la forza lavoro dalla quale dipende lo sfruttamento.
Una mossa che spesso ricorre nel dibattito accademico, si chiama “combattere un argomento fantoccio”. Si costruisce un ‘uomo di paglia’ e gli si dà fuoco. Una visione così ristretta e banale del marxismo in pratica non è stata mai sostenuta da nessuno, e sicuramente non dai fondatori. Peraltro, facendo mente alla definizione amplissima proposta di “riproduzione” questo modo di allargare la definizione di “lavoro” (e classe) fino ad includerlo in pratica rende ogni cosa della vita, incluso quel che sto facendo ora, lavoro. Si tratta chiaramente di una definizione con la quale non ce ne si può far nulla.
La Jaeggi reagisce a questa posizione qualificandola in modo sottile come un “concetto produttivo”, ovvero come quel che è, in sostanza, un utensile per uno scopo, quello di recuperare la tradizione delle lotte identitarie entro la necessaria ripresa del tema dello sfruttamento materiale. In altri termini un termine polemico. Ma pone con precisione chirurgica il punto che la nostra cerca di avvolgere in una coltre di nebbie: “sto ancora cercando di capire se si tratta di un’aggiunta alla o di una sostituzione della lotta di classe”. La risposta è che si tratta di un ‘né/né’. Non aggiunte e non sostituite. Le lotte di confine si sovrapporrebbero e intreccerebbero alle lotte di classe, la distinzione è in sostanza questione di prospettiva. La distinzione sarebbe analitica (come l’intera architettura concettuale marxiana, in effetti) e molto spesso, ammette, le lotte di confine sono sovradeterminate da questioni di classe. Ma questo non significa che ogni lotta debba essere espressa “solo o soprattutto” come una lotta di classe (e prosegue, richiamando l’uomo di paglia, “almeno non in senso stretto, ortodosso”).
Senza alcuna comprensione per lo sforzo erculeo di muoversi sull’orlo dell’abisso dell’americana, a questa posizione la tedesca replica chiarendo che ci sono dimensioni di lotte di confine “che non possono essere coperte dal vocabolario di classe, per cui non avrebbe senso tradurle in una lotta di classe”. Un ottimo esempio sono le lotte ambientali (se pure l’impatto di esse cade diversamente sulle diverse classi) e un altro è il “femminismo del tetto di cristallo” contro il quale la stessa Fraser si spende sempre e con il quale apre il suo “Femminismo per il 99%”[30]. Apparentemente senza cogliere la profondità della sfida, questa replica che “il capitalismo”, consolida normativamente “strutture ingiustificabili di dominio lungo le linee di classe, ma anche lungo altri assi trasversali: genere, razza o etnia, nazionalità”. Insomma, il capitalismo è tutto.
Un quadro che la Jaeggi giudica offrire molte possibilità, ma anche “piuttosto confuso”[31].
E soprattutto che non consente di distinguere tra lotte regressive ed emancipatorie (cosa che, ad esempio, la priorità per la liberazione/dissolvimento della classe fa). O, nel gergo filosofico novecentesco: se non si vuole ricadere in una concezione essenzialista della giusta definizione di confini (o “sfere”), come si può delineare nel vasto quadro disegnato dalla Fraser quali lotte vadano sostenute e quali avversate?
Una domanda alla quale in effetti non ha risposta. I criteri che propone sarebbero: il “non dominio” (lungo tutti gli assi indicati parallelamente), la “sostenibilità funzionale”, la “democrazia”.
Non mi pare che la mappa del labirinto sia stata scoperta.
[1] – Constellations è un giornale accademico di critica e teoria democratica edito da Jean Cohen, Amy Allen e Andreas Kalyavas.
[2] – Ad esempio, “Nancy Fraser, ‘Come il femminismo divenne ancella del capitalismo’”, e “Nancy Fraser, ‘Contro il neoliberismo progressista, un nuovo populismo progressista’”, Nancy Fraser, ‘Il vecchio muore ed il nuovo non può nascere”; Nancy Fraser, “La fine della cura”; Nancy Fraser, “Cosa significa socialismo nel XXI secolo” .
[3] – Nancy Fraser, “Fortune del femminismo”, Ombre Corte, 2013.
[4] – Cinzia Arruta, Tithi Bhattacharya, Nancy Fraser, “Femminismo del 99%”, Tempi Nuovi 2019.
[5] – Nancy Fraser, “Femminismo, capitalismo e l’astuzia della storia”, 2009, in , “Fortune del femminismo”, op.cit.
[6] – Di cui abbiamo letto, Axel Honneth, “Reificazione”; Axel Honneth, “L’idea di socialismo”; Axel Honneth, “Il diritto della libertà”.
[7] – Rahel Jaeggi, “Alienazione”, Editori Riuniti 2013, ed. or. 2003.
[8] – Rahel Jaeggi, “Forme di vita e capitalismo”, Rosemberg & Sellier, 2016.
[9] – Jurgen Habermas, “Teoria dell’agire comunicativo”, Il Mulino 1986, ed. or. 1981.
[10] – Fraser, op.cit., p.22
[11] – Si veda, per un tentativo di ricostruzione e critica di questa mossa del “femminismo della differenza”, il post “Pochi appunti sul ‘femminismo della differenza’”.
[12] – Ivi., p. 313.
[13] – Si veda in proposito la polemica tra John Smith e David Harvey nel post “Dibattiti sull’imperialismo: John Smith contro David Harvey”, e quello tra Utsa e Prabhat Patnaik e lo stesso David Harvey in “Un dialogo sull’imperialismo: David Harvey e Utsa e Prabhat Patnaik”.
[14] – Fraser, Ivi., p.316.
[15] – Fraser, op.cit., p.40.
[16] – Ivi, p. 57
[17] – Quell’assetto tipico delle società “opulente” della parte centrale del secolo scorso (diciamo dagli anni venti agli anni ottanta) nella quale in media un solo membro della famiglia, quasi sempre il maschio, lavorava all’esterno come dipendente prelevando un “salario” in grado di mantenere l’intera famiglia, e quindi demandava la gran parte delle attività di ‘cura’ al partner che restava a casa.
[18] – Angela Davis, “Donne, razza e classe”, Alegre, 2018 (ed. or. 1981).
[19] – Nancy Fraser, “La fine della cura”, op.cit.
[20] – Rosa Luxemburg, “L’accumulazione del capitale”, PGreco 2012 (ed. or. 1912).
[21] – Fraser, “Capitalismo”, cit, p. 78
[22] – Ivi., p. 116
[23] – E’ il tema del libro di Nancy Fraser, “La fine della cura”, o, più avanti, delle pagine 132-136 che ne riproducono molti passaggi.
[24] – Ivi., p. 127
[25] – Ivi., p. 169
[26] – Ivi, p.172
[27] – Ivi, p.172
[28] – Termine centrale nella teorizzazione che la Jaeggi condivide con Honneth.
[29] – Fraser, Ivi. p.245
[30] – Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya, Nancy Fraser, “Femminismo per il 99%. Un manifesto”, cit.
[31] – Fraser, ivi, p.261
Fonte articolo: http://tempofertile.blogspot.com/2021/05/nancy-fraser-capitalismo-una.html